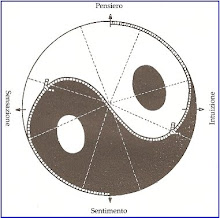| Avatarmovie.com |
Stesso cinema: l'Adriano, anche se trent'anni dopo.
Trentuno, per l'esattezza. Stessa formazione: io e mio padre.
Certo, all'epoca, l'Adriano non era un multisala a tre piani con le scale mobili e i pavimenti sbrilluccichini.
Nossignore, era un'unica immensa sala a pian terreno con le poltroncine nemmeno troppo comode, una predominanza di colori grigio-topo e marrone-marcio, l'audio un po' scassato e rimbombante, dove, non troppi anni prima, si narra si esibissero gruppi addirittura come i Beatles.
L'Adriano, a Roma, non era un cinema, era IL cinema, oltreché sala da concerto, all'occorrenza.
L'Adriano era un'istituzione, un posto per famiglie la domenica pomeriggio, un posto per coppiette il sabato sera, un posto per le nonne di Prati e Borgo dove portare le nipoti, il sabato pomeriggio, a vedere i film di Celentano o Bud Spencer e Terence Hill.
Un posto dove i nonni portavano le amanti per far bella figura, salvo poi incontrare le mogli con le nipoti e rovinare il sabato pomeriggio a tutti. Ma questa è un'altra storia.
Il posto perfetto, insomma, per un padre, sua figlia e la Saga di Guerre Stellari.
Stesso cinema, anche se trent'anni prima.
Stessa pietra miliare nell'industria cinematografica.
Stessa formazione: io e mio padre.
Ci mancano i pop-corn e siamo due bambini perfetti.
Ma, all'epoca, bisognava dare il buon esempio e, quindi, niente schifezze da mangiare.
Poco importa perché quello che importa veramente è fluttuare nel buio della sala sospesi nel cosmo spaziale, fuggire a bordo di qualche astronave o a cavalcioni di qualche astrusa creatura aliena, dare la mano a C1-P8, chiedere alla mamma gli chignon della Principessa Leila, sognare un bacio di Luke Skywalker o Ian Solo, avere Chewbecca come orsacchiotto personale e credere che tutto sia perduto prima che, proprio a un attimo dalla fine, il Bene trionfi.
Poco importa perché quello che importa veramente è la fluorescenza delle nostre spade laser e, ci puoi giurare, il ronzio che fanno, proprio a fianco dei nostri sedili.
Poco importa perché quello che importa veramente è che, per ogni episodio della Trilogia nel corso degli anni, siamo rimasti dentro al cinema a vedere due volte di filato lo stesso spettacolo, incollati alle poltrone come se dipendesse da noi la sconfitta dell'Impero e, ogni volta, mamma si preoccupava per che fine avessimo fatto e, ogni volta, la maschera del cinema ci guardava storto perché pagavamo una sola volta il biglietto ma, all'epoca, di computer e posti numerati ancora non se ne parlava e si poteva osare.
Stesso cinema, l'Adriano. Stessa formazione: io e mio padre.
Ci mancano i pop-corn e siamo due bambini perfetti.
Ma, oggi, il colesterolo è un po' alto e, quindi, niente schifezze da mangiare.
Stessa pietra miliare nell'industria cinematografica: Avatar.
Ci sono voluti trent'anni (Signore degli Anelli a parte) perché potessi riprovare in un cinema le stesse emozioni, gli stessi brividi sottili, lo stesso senso di stupore e meraviglia e novità, nel cuore e davanti agli occhi. Trentuno, per l'esattezza.