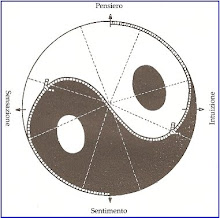martedì 26 ottobre 2010
MICE PARADE LIVE IN ROME @ INIT
Apre le danze della serata all'Init Silje Nes, timida uccellina delle lande della Norvegia e ora residente a Berlino, dalla voce delicata e le slanciate movenze elfiche, in tour per il suo secondo album uscito per la FatCat Rec, Opticks, e missato da Bernd Jestram dei Tarwater.
Si dividono il palco in tre, lei, con la sua chitarra e i mille effetti e pedali, un violinista/bassista e un altro che suona ciò che resta di una batteria, percussioni elettroniche e anche un po' il glockenspiel e la chitarra.
Sono sognanti, rarefatti, dilatati. Un delicato miscuglio di suoni elettronico-acustici e un inizio dolce che avrei ascoltato volentieri più a lungo dei venticinque minuti scarsi loro concessi.
Poi arriva lei, la navigata matrona francese, Laetitia Sadier, già Stereolab. E' difficile raccontare le sensazioni che questa eclettica e carismatica donna riesce a profondere intorno a sé. Innanzitutto viaggia sola, lei e la sua chitarra da mancina. Nuda e cruda, zero effetti, mesmerica ma umile presenza, voce matura, vibrante, intensa. Su testi impegnati, in inglese e francese, (un pezzo dedicato a Pasolini e uno in cui ironizza su Sarkozy) ci regala le sue melodie eleganti accompagnate da armonie scarne, intesse ghirigori raffinati che salgono dalle basse profondità delle note quasi da contralto alle vette cristalline dei suoni da soprano, come una Joni Mitchell europea e post-moderna.
Grazie, Laetitia, perché fai arrivare al pubblico cosa vuol dire essere donna, cantante, artista, modesta e di spessore, tutto in una sola volta.
Verso le 23.00 arrivano i Mice Parade, trafelati e in ritardo, da Torino, come ci informa lo stesso Adam Pierce, simpatico ragazzone newyorkese e leader della band. Il che (l'essere in ritardo da Torino) comporta un estenuante sound-check dal vivo a cui dobbiamo assistere tutti per quaranta lunghi minuti.
Io sono piazzata, come al solito, davanti al mio sub-wooferone centrale preferito, dove appoggio, per comodità, borsa, giacchetto e ginocchia a rotazione. Adam si scusa più volte anche se il pubblico lo rassicura. Io stessa gli dico: "We can wait" anche se, al quindicesimo minuto, già mi pento della mia affermazione.
L'attesa, per fortuna, viene poi ampiamente ripagata dalla bellissima performance che i sei musicisti ci regalano. Doppia batteria sul palco, una per lo stesso Adam (quando non è impegnato a suonare le sue due chitarre o il mandolino o a cantare o a percuotere il cubo di legno che gli funge anche da sedile) e l'altra, ovviamente, per Doug Scharin (che Dio ti benedica, Doug, per il grande, immenso batterista che sei) quando non è impegnato a maneggiare mixer, suoni e rumori alla sua destra o a suonare il basso. Poi ci sono la bambinesca e angelica voce di Caroline Lufkin (piazzata davanti a un Mac che, probabilmente, le serve per fare solitari di Mahjong tra un pezzo e l'altro o anche tra un cantato e l'altro dello stesso brano, momenti in cui lei si accovaccia timidamente dietro al Mac in questione come se la faccenda non la riguardasse più), la chitarra del virtuosissimo Dan Lippel e, infine, un tastierista/bassista e un altro chitarrista/tastierista. Dal vivo sono insolitamente energici rispetto al sound che si ascolta nel loro ultimo lavoro, What it means to be left-handed, (settembre 2010, sempre FatCat Rec) album del quale eseguono quasi tutti i brani in ordine sparso, con tempi leggermente più veloci e in modo molto più grintoso e dilatato.
L'elegante commistione di musica indie, elettronica, folk cantautoriale, ritmi africani e brasiliani, in ambito live, rende perfettamente e lascia ulteriore spazio a molto flamenco e un po' di post-rock.
Questa sera la folla è stranamente silenziosa ed educata. Abbiamo però a che fare con un nuovo tipo di fauna: l'ubriacone-fattone-perso. L'individuo, ovviamente schierato sotto al palco, alla mia destra, si esibisce in danze traballanti e in improvvise esplosioni di vitalità alternate a rallentate inversioni a u su se stesso. E' circondato da un paio di amici, per fortuna un po' meno ubriachi di lui, che lo accudiscono come si farebbe con un bambino piccolo: lo fanno ballare, giocare e lo abbracciano. Quando cade amorevolmente lo rialzano e controllano che non sia troppo fastidioso con le altre persone presenti in sala. Lo stordito scatena spesso l'ilarità degli stessi musicisti e tenta di offrir loro piccoli grappoli d'uva tirati fuori da chissà dove. Adam e Caroline gentilmente declinano. Dan, il seicordista flamencoso, coraggiosamente, accetta qualche acino e se lo ingolla. Evidentemente soddisfatto, lo stonato comincia a franare, lentamente e inesorabilmente, di schiena, sulla mega cassa del sub-woofer centrale.
Io faccio appena in tempo a sollevare borsa e giacchetto e lui tramortisce così, a cinque centimetri dal mio ginocchio.
Niente bis ma solo perché è tardi, è venerdì e c'è la discoteca.
sabato 23 ottobre 2010
N.A.M.B. - .B.M.A.N
E' difficile recensire questo eterogeneo e prolisso nuovo album dei N.A.M.B.
BMAN esce, in prima battuta a ottobre 2009 in Italia ed Europa e a febbraio 2010 negli Stati Uniti, per la britannica Monotreme Rec e a distanza di quattro anni dall'album s/t di debutto uscito, invece, per la Mescal.
E' un progetto ambizioso, un concept album di ben 18 canzoni che, sulla scia di Wall-e, narra le avventure di un piccolo robot, di nome Bman, alla scoperta di se stesso e di ciò che resta dell'umanità.
Questo aspetto è stato una delle prime cose a incuriosirmi molto perché vede l'interazione tra musica e arti grafiche, avendo, Bman, preso forma e vita, sulla carta, nelle sapienti mani di Maq4ka, in una sorta di ciò che potremmo definire music-novel, ossia una graphic-novel trasposta in ambito sonoro: non è un romanzo o un racconto, in questo caso, ad essere trasformato in fumetto ma una pièce musicale a diventare illustrazione e le illustrazioni stesse, di rimando, ad ispirare il materiale sonoro.
Musicalmente parlando i N.A.M.B., acronimo sul quale la band riserva un alone di mistero e di democratico "qualunque cosa voi vogliate sia", nascono a Torino intorno al 2004 e, attualmente, presentano la seguente line-up: Davide Tomat (voce, chitarra, programming, carillon, batteria), Gabriele Ottino (cori, chitarra, farfisa, programming, basso, batteria), Silvio Franco (basso, chitarra, synth, piano, programming) e Davide Compagnoni (batteria, programming, loop station).
In questo nuovo lavoro abbandonano la madrelingua italiana usata nel primo album, tranne che per il geniale e stralunato Musichetta in pausa sigaretta, a favore dell'inglese, per un più ampio respiro internazionale, anche se alcuna critica americana li taccia di usare un linguaggio inappropriato e nonsense.
Addentrarsi nella definizione dei generi risulta impresa piuttosto ardua: c'è sicuramente una base di elettronica, del rock psichedelico, un pizzico di industrial, un condimento di indie e un retrogusto di inevitabile matrice italiana. Dall'inizio alla fine del disco non riesci a capire se facciano della musica mainstream travestita da musica di nicchia o, al contrario, della musica alternativa che strizza l'occhio al versante più pop. Il che li rende sui generis ma anche poco schierati e difficilmente fruibili da entrambi i lati del pubblico, sia esso underground o, appunto, popolare.
Quello che a me arriva, come primo impatto, è la seguente amalgama di sensazioni: sembra che i N.A.M.B. stiano rielaborando una più moderna versione (e con meno forme-canzone) degli U2 di Acthung Baby, suonati un po' dai Subsonica e un po' dai Nine Inch Nails, interpretati un po' dal Mike Patton dei Peeping Tom e un po' dal John De Leo dei Quintorigo, supportati sonoramente dai Primal Scream e da una pletora di suoni-giocattolo distorti e carillon malati e ubriachi.
Se vi state chiedendo se l'album mi sia piaciuto o meno, onestamente, non riesco a capirlo ancora nemmeno io. Continuo ad ascoltarlo volentieri, un po' con amore e un po' con perplessità.
Sicuramente con una grandissima ammirazione per tanta fertilità produttiva, per la bellezza cristallina dei suoni e la cura certosina di missaggio e mastering.
giovedì 21 ottobre 2010
GEOFF FARINA AND CHRIS BROKAW LIVE IN ROME @ INIT
Ok, sbrighiamo le formalità.
Geoff Farina (ex Karate, Glorytellers e Secret Stars) e Chris Brokaw (ex Come, Codeine e Pullman) hanno recentemente inciso per la Damnably Rec (mercato europeo e britannico) e per la stessa etichetta di Brokaw (mercato statunitense) la Capitan Rec, due dischetti usciti in primavera e in autunno 2010, The Angel's Message To Me e The Boarder's Door.
Due chitarre acustiche, due voci, una manciata di brani classici della musica country-blues e qualche pezzo scritto, invece, di proprio pugno dai nostri.
Il loro modo di suonare il country, anche nelle rivisitazioni dei classici, è più riflessivo, cantautoriale, rallentato, contaminato dalla neve silenziosa e dal freddo solitario del Nord-Est, rispetto a quello tipico americano del Sud, sfavillante, galoppante e incline alle velocità circensi.
E' lo stesso Geoff ad informarci che ha trascorso l'ultimo anno nel Maine, un posto molto "cold and lonely", che lo ha portato a scrivere un paio di pezzi altrettanto "cold and lonely".
Cominciano insieme, poi Chris lascia in solo Geoff, poi viceversa, poi concludono di nuovo insieme.
Geoff ha una voce sgranata e velata, si esibisce in un finger-picking discretamente virtuoso, i suoi testi sono poetici, impegnati, ricercati. Ha un piglio costantemente altero e serioso, è compreso nella parte ma sempre un po' distaccato. Chris ha un timbro leggermente più potente e un approccio più sanguigno, nel modo di cantare e anche in quello di suonare la chitarra.
Sono semplici, onesti, appassionati di quello che fanno, e richiedono silenzio e attenzione, come tutte le cose delicate e poetiche.
Io che pensavo di rischiare l'effetto soporifero, dopo il terzo pezzo di arpeggi dolci e voci malinconiche, invece, mi ritrovo cullata e immersa in un'atmosfera sognante e scarna.
Cerco di concentrarmi sul significato dei testi anche se, ovviamente, non essendo madrelingua, mi perdo qua e là qualche parola.
Il pubblico sparuto, nonostante la presenza di tre coppie rumorose e un gruppetto di amici ubriachi e molesti, è coinvolto e caloroso e riesce a strappare ai due anche un paio di bis, nonostante Geoff non smetta di indirizzare occhiatacce di disappunto ai cafoni presenti in sala e il povero Chris sia costretto, scusandosi per giunta, a richiedere un po' di silenzio: "I'm trying to concentrate up here ...", dice.
E ora cominciamo con l'invettiva.
Quello che non smetterò mai di chiedermi è perché, perché, perché, Santo Dio perché, la gente venga ai concerti per chiacchierare, a voce alta per altro.
Non mi rifugerò nemmeno in rituali formule di cortesia quali "secondo la mia umile opinione" o "sicuramente mi sbaglierò io".
No, no. E' così e basta. E vi sbagliate VOI.
Voi. Che venite ai concerti e non sapete nemmeno voi perché.
Voi. Che fate presenza alle serate e non ne capite l'essenza.
Voi. Che dissacrate l'arte e vanificate il duro lavoro che c'è dietro ogni sforzo di comunicare emozioni, sensazioni e sfumature.
Voi. Che Dio vi dovrebbe recidere le corde vocali e amputare le lingue e insegnare come si sta al mondo.
Voi. Che ma chi ve lo fa fare di spendere 10 o 15 euro, se non di più, soltanto per disturbare la bellezza di qualcosa che non sapete apprezzare e l'attenzione di coloro i quali vanno ai concerti per fare quello che dovrebbe essere fatto: ascoltare.
Per favore, se volete fare salotto o sfoggiare il vostro ultimo look, andatevene al Gilda o al pub sotto casa o in giro per il centro. O, perlomeno, restate fuori.
Grazie.
sabato 16 ottobre 2010
domenica 10 ottobre 2010
THIS WILL DESTROY YOU LIVE IN ROME @ INIT
La serata all'Init è piena zeppa di gente. Fila per entrare, porte rigorosamente chiuse fino alle 22.15 e non si comincia prima delle 22.45.
Ormai, per gli orari dei concerti, non so più come devo regolarmi.
Apre la serata la formazione romana dei Refuso che sta incidendo il suo primo album e, nel frattempo, si esibisce parecchio, tra Roma e Berlino.
La band conta ben sette elementi: l'ispirato Andrea Treccia D'Amico al basso, Daniele Casolino al piano, Dario Calfapietra alla chitarra e glockenspiel, Valerio Iammartino all'altra chitarra e voce, Pietrina Mancini al violoncello, Martina Pelosi alla voce e Matteo Ambrosetti alla batteria.
La loro musica è un singolare miscuglio di post-rock Pink Floyd-iano, prog un po' psichedelico, atmosfere leggermente folk e pop italiano impegnato.
Affiatati, bravi tecnicamente e dediti. Il mio gusto personale mi farebbe suggerir loro di rendere i cantati (nonostante la bella voce e le indubbie capacità tecniche e di estensione di Martina) meno invasivi, per evitare l'effetto Anna Oxa meets Rachels.
Il che, però, potrebbe essere anche un tratto distintivo. Come ho premesso, il gusto è personale.
Dopo un abbastanza rapido cambio-palco, arrivano i nostri magnifici quattro che stanno per affrontare le ultime date del tour europeo (che si concluderà il 17 ottobre con gli ultimi tre concerti in Romania, dopo aver effettuato un estenuante tour de force che li ha visti aprire, in giro per gli USA, durante tutto agosto e buona parte di settembre, per gli Autolux e i Deftones) in occasione dell'uscita del loro ultimo album Tunnel Blanket per la Magic Bullet Rec.
I This Will Destroy You sono quattro texani ruvidi e un po' marci, tranne il batterista, Alex Bhore, che, oltre ad essere bravissimo, sembra anche essere
l'unico bravo ragazzo: non beve, non fuma, parla e sorride a tutti, a differenza dei tre restanti membri del gruppo che sembrano come avvolti da una sorta di torpore dionisiaco, lievemente autistici e chiusi in una specie di timidezza un po' sprezzante. Gli altri, appunto, Donovan Jones (basso a 5 corde, catafalco tastieroso tipo moog e suonetti vari), Chris King (chitarra e faccia in trance del fu Michel Petrucciani durante gli assoli) e Jeremy Galindo (chitarra, campionamenti e suonini vari, compresi lamenti di voce distorta) fumano sul palco e si passano whiskey e birre senza rispetto per la continuità della gradazione alcolica.
In faccia leggi loro la sofferenza di quelli che la musica la sentono nelle corde e nel sangue, come sentono il male della vita e il peso dell'arte.
E, un po', è un atteggiamento ostentato à la maudit e, un po', è il segno caratteristico di coloro i quali si ritrovano a vivere un destino che, seppur piacevole, in fondo non hanno scelto, come, del resto, capita a tutti noi. Questo Vi Distruggerà, evidentemente, non un nome a caso.
Insieme hanno un sound profondo e potente, radici rurali di un post-rock sospeso nel tempo che ti entra sotto la pelle e ti scuote le budella.
I megabassi del sub-woofer centrale, davanti al quale mi sono piazzata, spostano con vibrazioni vigorose la mia gonnellina e la falda degli stivali appena sotto alle ginocchia.
Le dinamiche vanno su e giù di continuo, come montagne russe in cui lente ed emozionanti salite precedono discese sfrenate e vertiginose, e la tempesta arriva dopo la quiete e poi ritorna la quiete e poi, di nuovo, la tempesta.
I pezzi sono tutto un susseguirsi di laghi calmi di chitarre rarefatte a cavalcate dirompenti di batterie energiche, ritmi spezzati e, a volte, quasi tribali. Loop reiterati, esplosioni rumorose, suoni allungati e distorti, accordi dolci e veemenza graffiante. E, saranno pure in ritardo di quasi dieci anni e i gruppi di riferimento li potrebbe
elencare anche un (indie)bambino (Mogwai, Explosions in the Sky, God Speed You! Black Emperor e anche un po' Labradford) ma la folla si esibisce in semi-lenti eppur vitali head-banging.
Applausi, trasporto, delirio.
Ad avercene di post-rock così. In Italia e nel mondo.venerdì 8 ottobre 2010
LOVE AMONGST RUIN LIVE IN ROME @ CIRCOLO DEGLI ARTISTI
Arrivo in ritardo, come al solito, in tempo per sentire giusto l'ultimo pezzo del gruppo d'apertura, i romani Spiral 69, i quali mi sembra facciano un onesto pop-rock un po' new wave e appena gotico, con voce maschile e bella pianista darkettona al seguito, e promuovono il loro primo album, A filthy lesson for lovers uscito il 5 ottobre per la Megasound rec.
Poi, dopo un bicchiere di vino, mi guardo intorno e comincio a studiare la situazione.
Quando ci sono Inglesi e soldi c'è professionalità.
C'è un banco vendite che sembra una tavola imbandita per dodici persone con magliette di tutti i tipi, album, singoli, posters, borse, spillette (chi più ne ha più ne metta) e ben due (e dico due) addetti allo smercio di cotanta abbundantia.
Questo fatto mi spinge alla prima ponderosa riflessione su come oggi tutto sia consumistico e precorritore della sostanza stessa di un fenomeno. Mi spiego meglio. Come fa una band formatasi soltanto un paio di anni fa e della quale, comunque, l'album omonimo di debutto è uscito da appena poco più di un mese (tramite la stessa etichetta di Hewitt, la Ancient B rec), come fa una costola infelice nata dalla singola cenere di un'altra band (i Placebo) che, almeno, aveva (ha) dalla sua parte caratteristiche di personalità e peculiarità, ad avere GIA' quattro diversi tipi di magliette e un armamentario degno dei Pink Floyd all'apice della loro carriera?
Non dovrebbero PRIMA diventare famosi e POI atteggiarsi a tali?
Ma, quando ci sono Inglesi e soldi, c'è marketing. Poi ci sono l'accordatore sul palco (prima che entri la band) e l'omino tutto-fare che si aggira, indaffarato, controllando i collegamenti dei vari cavi, distribuendo bottigliette d'acqua (due a persona), asciugamani bianchi detergi-sudore e attaccando i fogli delle scalette con lo scotch-carta. Il tutto per ogni membro della band.
E sono sei. Lui, Steve Hewitt, l'ex-batterista dei Placebo, appunto, usa la voce, il tamburello e una chitarra da mancino, poi c'è la prima chitarra (Steve Hove), la seconda chitarra (Donald Ross), la donna bassista e contrabbassista elettrica (Teresa Morini), il batterista (Keith York) e il tastierista, suonatore di piatto singolo e tamburello e, all'occorrenza, anche suonatore di violoncello elettrico (Laurie Ross).
Mancano due cose fondamentali: la musica e la gente. La gente perché, come dicevo già ieri, questo mondo produce troppo e apprezza poco e, forse, in questo caso, ha ben poco da apprezzare. Al di là di considerazioni personali, stare dietro a tutti questi concerti, per non parlare di tutti i dischi, comporta un notevole dispendio in termini sia di energie fisiche che di soldi. E poi la musica. Diciamo un buon (???) pop-rock molto tradizionale, senza infamia né lode, indubbiamente ben eseguito ma senza calore. A me non arriva un colpo al cuore, né uno spruzzo di sudore, né una goccia di sangue, né una bava di saliva, né il graffio di un suono o il guizzo di un'originalità. Niente di niente. Soltanto una sequela di note banali, in stilemi integralmente precostituiti, vecchi, aridi, patinati e plastificati. Leggo altre recensioni in cui i Love Amongst Ruin vengono accostati ai Depeche Mode (?), ai New Order (??), ai Kasabian (!), ai Metallica (?!), ai Can (??!!) e mi domando come sia possibile.
Mancano due cose fondamentali: la musica e la gente. La gente perché, come dicevo già ieri, questo mondo produce troppo e apprezza poco e, forse, in questo caso, ha ben poco da apprezzare. Al di là di considerazioni personali, stare dietro a tutti questi concerti, per non parlare di tutti i dischi, comporta un notevole dispendio in termini sia di energie fisiche che di soldi. E poi la musica. Diciamo un buon (???) pop-rock molto tradizionale, senza infamia né lode, indubbiamente ben eseguito ma senza calore. A me non arriva un colpo al cuore, né uno spruzzo di sudore, né una goccia di sangue, né una bava di saliva, né il graffio di un suono o il guizzo di un'originalità. Niente di niente. Soltanto una sequela di note banali, in stilemi integralmente precostituiti, vecchi, aridi, patinati e plastificati. Leggo altre recensioni in cui i Love Amongst Ruin vengono accostati ai Depeche Mode (?), ai New Order (??), ai Kasabian (!), ai Metallica (?!), ai Can (??!!) e mi domando come sia possibile.
Poi mi ricordo che, quando ci sono Inglesi e soldi, a volte, ci sono anche gigantesche operazioni commerciali. Ne avevamo bisogno?
mercoledì 6 ottobre 2010
OH NO ONO LIVE IN ROME @ MADS
Malthe Fischer, il cantante principale della band, esordisce sul palco, in un solo di voce e chitarra, come uno stralunato folletto del Nord con la voce di Topo Gigio, in un brano intitolato Sunshine and rain at once, tratto dal primo album, Yes. L'unico pezzo lento e ammaliante.
Poi si aggiungono l'altro cantante/bassista/tastierista/sampleratore Nis Svoldgard, il terzo cantante/chitarrista anch'egli sampleratore Aske Zidore e l'ottimo batterista Kristoffer Rom, occhialetto da nerd e click in cuffia.
Poi arriva Ba ba baba ba ba well anyway, sempre dal primo disco, in cui sembrano dei vaghi Beach Boys macchiati di punk elettronico.
Punk è l'attitudine con cui suonano: tanta energia, buona amalgama e non troppa tecnica. Arrivano altri tre pezzi da Eggs: Eleanor speaks, Internet warrior e Icicles in cui sembrano dei vigorosi Beatles ubriachi e dei Supertramp post litteram.
Poi si torna a una canzone tratta da Yes, Am I right? in cui sembrano dei Sigur Ros invasati dai Ramones, si procede con The wave ballet, che apre con uno shoe-gaze alla My Bloody Valentine contaminato di cantati pop, la bellezza sconvolgente di The tea party, l'energia pura di Keeping warm in a cold country(Yes), l'electro-funk-punk, disco-malata e post-moderna di Practical money skills for life (Yes), il rock&roll puro venato di new-wave con una cantilena dei Fiordi di Miss Miss Moss, e, infine, Fat Simon says con degli insoliti e difficili cambi di ritmo, tratto dal primo EP.
Applausi, tanti, di una compagine sparuta, in un mondo che, purtroppo, produce troppo e apprezza poco.
I nostri tornano per il bis: una splendida cover di Tomorrow never knows dei Beatles, con guest del tour-promoter che sale sul palco e imbraccia la chitarra, unendosi ai suoi protetti. Gli Oh No Ono rendono onore a questo pezzo come pochi altri: attaccano con ritmi tribal- indianeggianti e, poi, diventano sempre più potenti, energici, esplosivi, estenuanti. Un finale come dovrebbero essere tutti i finali: memorabile.
Come sorpresa ultima, al banco CD, spille, gadgets e magliette, i prezzi sono più che politici: a discrezione dei clienti!
Mi porto a casa due magliettine dall'estetica curata e avant-garde, pensando che, come al solito, dal Nord Europa abbiamo solo da imparare.
domenica 3 ottobre 2010
BLACK MOUNTAIN LIVE IN ROME @ CIRCOLO DEGLI ARTISTI
Pronti per l'energia? Pronti, partenza, via.
Quaranta gli anni, (psichedelia) più o (rock classico) meno, in cui proiettarsi indietro nel tempo e quaranta i minuti che il Circolo degli Artisti dovrebbe aggiungere all'orario d'inizio dei concerti.
Perché, va bene la politica professional-britannica del suonare presto, finire presto (e non pulire il water) ma arrivare alle dieci spaccate e aver già perso un paio di pezzi dei Black Mountain è veramente troppo, calcolando anche la presenza di ben due gruppi d'apertura: i londinesi Goldenheart Assembly e gli australiani Night Terrors.
I nostri, invece, arrivano dal Canada e promuovono il loro terzo album uscito per la Jagjaguwar Rec, Wilderness Heart.
A guardarli bene, i Black Mountain, più che di Vancouver, sembrano cinque giovani fricchettoni appena usciti da uno scantinato californiano, un paio di estati dopo Woodstock e troppe estati prima dello stoner dei Kyuss, e, per caso, catapultati ai nostri giorni.
Le loro sonorità spaziano tra i Jefferson Airplane e i Quicksilver Messenger Service, per quello che riguarda l'impronta più psych-acid-rock, e la durezza energica dell'hard-rock e metal dei Black Sabbath, forse veri numi tutelari del gruppo.
Poi si tingono vagamente di echi Doors-iani, sulle ballate più blueseggianti, portano nel cuore la lezione dei Velvet Undreground, citano appena i Pink Floyd dei primordi e, sul terzo bis a chiusura del concerto, omaggiano anche il riff iniziale di You doo right dei Can.
Il tutto onestamente e incredibilmente cristallizzato in un insolito viaggio nel tempo, sospeso tra il miglior (roots) rock americano e l'heavy (blues) inglese, senza via d'uscita né ritorno.
La formazione vede Stephen McBean, leader, voce e chitarra della band, affiancato da Amber Webber come seconda cantante, Matt Camirand al basso, Jeremy Schmidt alle tastiere e Josh Wells alla batteria, tutti rockers immersi nella parte, tecnicamente
abili, navigatamente esperti e caldi come il sole californiano.
L'unico lieve dispiacere lo provoca soltanto la cantante femminile: incautamente posta al centro della scena come front-woman, meglio farebbe, invece, a spostarsi lateralmente come sider di Stephen.
Peccato, perchè la sua voce è bella, cristallina e pastosa, uno strano miscuglio di una Neko Case prestata al rock e macchiata di lievi tinte Celin Dion-iane, ma Amber, evidentemente di nome e di fatto, appare come una creaturina preistorica intrappolata nella resina della timidezza e dello stoccafissaggio. E su un rock come questo, proprio non si può.
Iscriviti a:
Post (Atom)






-1.jpg)